In certe immagini, la moda scompare. E resta solo
il mondo, nudo, feroce, commovente
|
Un ragazzo in punto di
morte. Un bacio proibito. Tre cuori umani, veri, esposti con cruda
verità, perché siamo tutti uguali. L’obiettivo non cerca più l’abito:
interroga le coscienze.
Nella mostra MODA e Pubblicità alla Fondazione
Magnani-Rocca c'è anche la
grande arte di Oliviero Toscani.
Negli
anni Ottanta e Novanta, Toscani trasforma la pubblicità italiana in un
teatro politico. Toglie il prodotto, lascia il logo. E nello spazio
sottratto inserisce la realtà: scabrosa, dolorosa, autentica. Le sue
immagini non illustrano: denunciano. Diventano icone, simboli di
un’epoca in cui la fotografia invade la sfera dell’arte perché non
consola, ma rivela. Anche
questo è arte: l’arte che disturba per far pensare. |
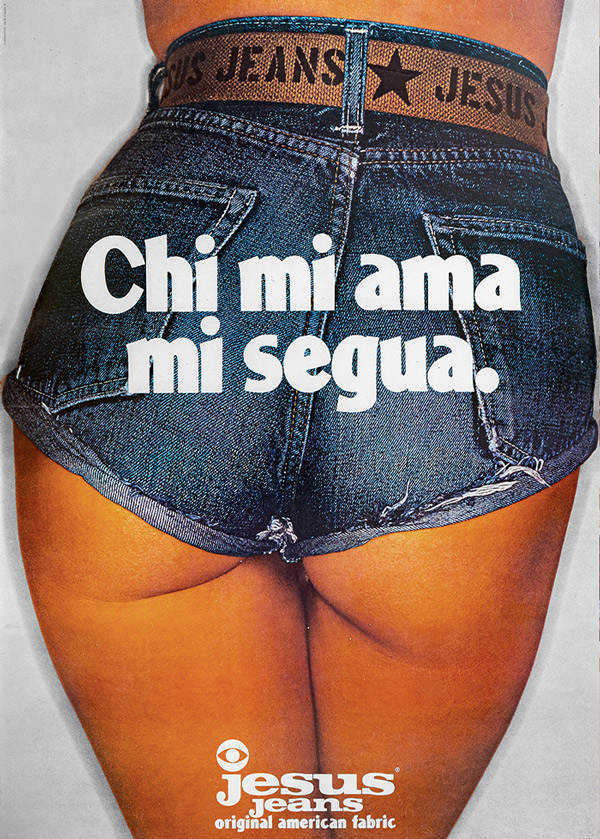 |
.jpg) |
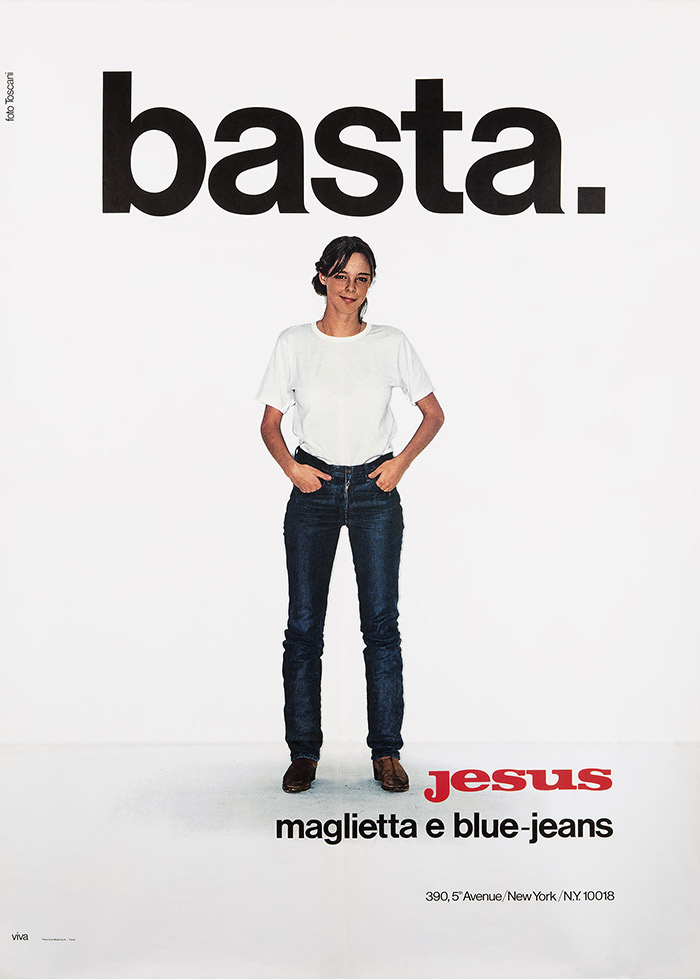 |
Tra il 1950 e il 2000
l’Italia attraversa una trasformazione profonda. L’ascesa industriale,
la nascita di una nuova borghesia dei consumi, la globalizzazione dei
mercati: è la stagione in cui il Made
in Italy diventa bandiera nel mondo. A cavallo tra gli anni
Settanta e Ottanta, il baricentro della moda si sposta da Firenze a Milano, cuore
dello stilismo — non solo abiti, ma linguaggi, stili di vita, iconografie diffuse su
riviste, insegne, televisione.
In questo scenario la pubblicità si
fa protagonista: un linguaggio pop e audace, capace di anticipare i
conflitti e le tensioni sociali.
Toscani
entra in questo dialogo: non come illustratore del desiderio, ma come autore che plasma la fotografia al centro del discorso pubblico. Accanto a lui, figure
come Barbieri,
Castaldi, Gastel e Mulas non sono solo nomi nel
calendario visivo italiano, ma punti di un immaginario collettivo
ridefinito. |
 |
Prima ancora che Benetton avesse un nome dominante, Toscani accende il dibattito. Con Fiorucci e
soprattutto Jesus
Jeans, rovescia il rapporto tra corpo e consumo. Gli
slogan di Emanuele Pirella — “Non
avrai altro jeans all’infuori di me” (1972), “Chi mi ama mi segua” (1973) — si impongono come frammenti poetici e scandalosi allo stesso
tempo, fino a provocare l’intervento di Pasolini, che parla di
“espressività mostruosa”.
Sul piano visivo,
Toscani definisce presto un linguaggio: fondi neutri, contrasti decisi,
figure centrali che emergono come simboli. Anche nei lavori per marche
come Lovable,
Prénatal, Robe di Kappa, il suo occhio cerca il segno più
che l’oggetto.
Nei primi anni ’80,
Toscani espande la sua visione: è un’epoca in cui la pubblicità
consolida il suo statuto semantico, e Toscani ne è alfiere. E poi la
svolta definitiva con Benetton (1984–2000). Lo slogan “United Colors of Benetton” sposta la scena dal
consumo al simbolo. I set sono asettici, le persone – di
etnie e generi diversi – sono poste sullo stesso piano. Il prodotto
arretra: il messaggio avanza.
E
infine l’atto radicale: l’eliminazione del prodotto |
> |
A fine anni ’80 inizia
una mutazione: Toscani si appropria del repertorio del fotogiornalismo
e, dal 1992, scarta
il prodotto. Restano immagini forti, prese “dal mondo”,
e un logo che diventa monito.
Tra i soggetti affrontati:
Razzismo e
inclusività
Migrazioni,
come lo sbarco albanese a Bari (1992)
AIDS,
con la rappresentazione del malato in fin di vita (1992)
Guerre
balcaniche, con la divisa insanguinata di un soldato
(1994)
Religione e tabù,
con il bacio fra un prete e una suora (1991-1992)
Pena di morte,
nei ritratti dei condannati nelle prigioni statunitensi (2000)
Questa stagione della “foto shock” dissolve le convenzioni del marketing e impone una dialettica critica.
Dove la moda promette evasione, Toscani consegna ferite. Nel 1997, la
sua affermazione poetica: “Qualsiasi
immagine è un’immagine politica.”
Il paradosso è che
quella radicalità non annulla il marchio: bensì lo rinsalda, rendendolo
riconoscibile non tanto per la giacca che non vediamo, ma per il valore
che appare.
L’esperienza di Toscani
si situa nel crocevia tra arte e pubblicità. Il
suo gesto riconfigura il perimetro della fotografia commerciale e lo
proietta in un campo critico: l’immagine non è più decoro ma riflessione.
Attraverso il suo lavoro, il Made
in Italy non è solo un brand, ma una narrazione globale:
non di lusso, ma di tensione, non di consensi, ma di contraddizioni.
Alla Fondazione Magnani-Rocca,
la grande mostra MODA E PUBBLICITÀ in Italia 1950 – 2000 accoglie le campagne di Toscani come un punto di svolta drammatico e
rivelatore. Non come episodio marginale, ma come momento in cui la moda
si volta e interpella il mondo. In
certe immagini, la moda scompare. Resta il mondo. E la sua verità,
anche quando brucia.
Visite
guidate
Sabato ore 16:00
Domenica e
festivi ore 11:30, 15:30, 16:30
Costo:
guida €5 + biglietto
d’ingresso €15
Prenota qui: prenotazioni@magnanirocca.it |
|
|
NELLA COLLEZIONE PERMANENTE |
La storia del dipinto Gio. Paolo Balbi a
cavallo di Anton Van Dyck
è una storia di congiure, cugini rancorosi e cancellazioni |
 |
Si tratta di una tela
del 1627, autografata dallo stesso Van Dyck. Ma nonostante la firma ben
visibile (si può vedere su una pietra in basso a sinistra) questo
quadro è stato per anni dimenticato dagli studiosi. Nel catalogo
generale dedicato a Van Dyck, realizzato nel 1980, il dipinto non è
presente nell’elenco delle sue opere. Come mai? Colpa del soggetto, e di suo
cugino - di secondo grado.
Anton Van Dyck è uno
dei pittori più corteggiati dall’aristocrazia del Seicento europeo.
Inizia a dipingere in giovanissima età, ispirandosi a Rubens, Tiziano e Giorgione.
Diventa un maestro del ritratto, dove arriverà al suo apice alla corte
reale inglese, ma passando prima da quella genovese.
Gio. Paolo Balbi era un
rampollo della famiglia Balbi di Genova. Dopo essere stato cacciato a
Milano per ripetuti crimini, nel 1648 viene smascherato come fautore di
una congiura contro la sua stessa famiglia. Impossibile da perdonare,
viene cancellato dalla vita della famiglia, e anche cancellato dal
dipinto che lo ritraeva, e considerato per sempre come “homo pessimus”.
Infatti, suo cugino
Francesco Maria Balbi, nel 1672 compra il quadro e incarica il
pittore fiammingo Simon du Bois di cancellare la faccia di Gio e
metterci - ovviamente - la sua. Di questo ci parlano gli scritti dello
storico dell’arte Bellori, ma si è potuto accertare solo con delle
radiografie. Nel 1983, infatti, dopo una importante decisione
conservativa, per mano del restauratore Ottorino Nonfarmale, la faccia
di Francesco viene eliminata per far riaffiorare quella di Gio.
Grazie al restauro
degli anni Ottanta possiamo leggere meglio la qualità di Van Dyck, che
ben esprime tutta la sfacciataggine di questo homo pessimus, che doveva
essere cancellato, ma che oggi è una delle star delle collezione della
Fondazione Magnani-Rocca.
Ascolta il pezzo dedicato al Capolavoro di Van Dyck
_______
La Fondazione Magnani-Rocca è una delle più importanti
istituzioni artistiche d’Europa.
La Villa dei Capolavori
di Mamiano di Traversetolo ospita la collezione di Luigi Magnani –
unica nel suo genere – con opere di Goya, Tiziano, Monet, Renoir,
Cézanne, Dürer, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio,
Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova e la più significativa raccolta di
Giorgio Morandi.
Immersa nella campagna
di Parma, la Villa conserva ancora oggi un fascino senza tempo con i
suoi arredi di epoca neoclassica e impero, circondata dal Parco
Romantico, un grande giardino all’inglese con piante esotiche, alberi
monumentali e gli antichi agrumi.
📍via
Fondazione Magnani Rocca 4, Mamiano di Traversetolo (Parma) |
Immagini
Immagini
Oliviero Toscani, United Colors of Benetton, collezione autunnoinverno
19901991. Courtesy Milano Manifesti © OLIVIEROTOSCANISTUDIO / Oliviero
Toscani, United Colors of Benetton, collezione primaveraestate 1990.
Courtesy Milano Manifesti © OLIVIEROTOSCANISTUDIO /
Oliviero-Toscani,-Jesus-Jeans-original-american-fabric-–-Chi-mi-ama-mi-segua,-1973.-Collezione-privata.-Courtesy-of-BasicNet-S.p.A
/ Oliviero Toscani, Jesus Jeans – Maglietta e blue-jeans. Basta, 1972.
Collezione privata. Courtesy of BasicNet S.p.A. Jesus® Jeans©
OLIVIEROTOSCANISTUDIO |
 > > |
|
|
|